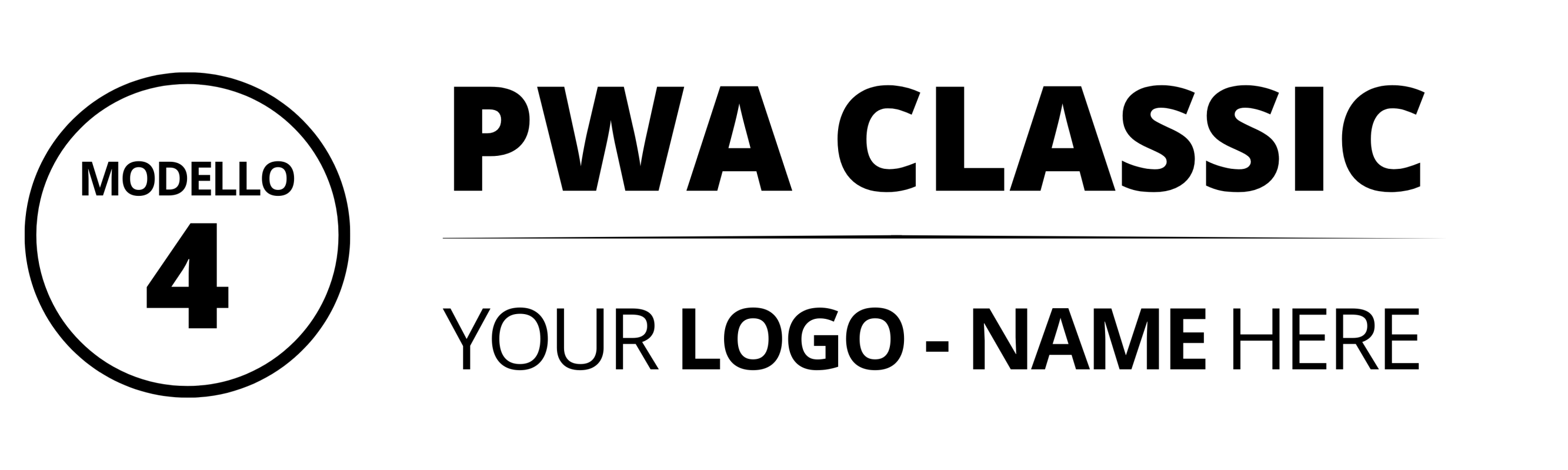Il sorteggio, questo conosciuto: nel nostro Paese è già un metodo di garanzia che non ha mai registrato resistenze, anzi, è utilizzato per tagliare ogni discrezionalità laddove possa fare dei danni. Questo da decenni. Così pure la riforma Nordio non sta inventando la ruota bensì un sorteggio "temperato" tra magistrati (eleggibili per titoli e anzianità) e si limiterà a estenderà un criterio collaudato a un organo costituzionale logorato dalle correnti. Non è un salto nel buio, ma una continuità con pratiche che già reggono altri pezzi sensibili dello Stato.
I tribunali. Quello dei ministri, anzitutto: dal 1989 in ogni tribunale del capoluogo di distretto c'è un collegio estratto a sorte con tre effettivi e tre supplenti scelti tra magistrati con almeno cinque anni di anzianità o qualifica superiore; si rinnova ogni due anni e a presiederlo è il più elevato in funzione. Parliamo dell'organo che indaga sui reati ministeriali e che rimette al Parlamento la richiesta di autorizzazione a procedere: la sorte decide chi debba condurre delle indagini su responsabilità politiche e funziona così da trentacinque anni, nessuno l'ha mai definito eversivo.
Le giurie. Il modello che tutti conoscono è quello delle giurie popolari. Nelle Corti d'Assise (primo e secondo grado) accanto ai due togati siedono sei giudici popolari estratti dagli albi comunali e dagli elenchi provinciali. I requisiti sono chiari (3065 anni, diritti civili e politici, titolo di studio) mentre per l'appello serve la scuola superiore. Lo stabilisce una legge del 1951 ed è un rito che affida alla sorte la scelta di chi giudica omicidi e reati gravissimi: e, se la casualità è ritenuta una garanzia per casi come questi, è piuttosto arduo sostenere il contrario quando serva a scegliere chi governa la magistratura.
I magistrati. Anche il reclutamento e l'organizzazione giudiziaria usano da sempre delle valvole di casualità. Nel concorso per magistratura le materie degli scritti sono estratte a sorte il giorno della prova: è un dettaglio con un senso, ossia limitare soffiate e vantaggi indebiti. La cornice è in una legge del 2006 e nella prassi ministeriale/Csm. La commissione invece non è sorteggiata (ma nominata) perché la logica è diversa e si guarda a responsabilità e merito.
L'anticorruzione. C'è l'esempio di quell'anticorpo che sono i revisori dei conti degli enti locali. Comuni e Province (leggi del 2011 e 2012) pescano i loro controllori con un'estrazione pubblica, e lo fanno da un elenco che è articolato per regioni e che è tenuto dal Viminale. Traduzione: il sindaco non nomina il proprio revisore. La sorte, anche qui, è temperata: si accede per titoli, e la Prefettura estrae.
Le università. Hanno codificato lo stesso principio nell'Abilitazione scientifica nazionale: i commissari che decidono l'accesso alle cattedre sono sorteggiati da un elenco di ordinari che hanno superato soglie e requisiti. Leggi del 2010 e 2011. Il senso è identico: togliere l'arbitrio e mantenere la qualità, stesso principio del sorteggio temperato che Nordio applica al Csm.
Le mediazioni civili. La regola è identica, e impone criteri imparziali e predeterminati per designare il mediatore; molti organismi (per evitare l'accusa di mediatori amici) usano rotazioni e sorteggi interni inseriti nei regolamenti. Non è un obbligo di legge, ma una prassi che dimostra che, quando si vuole neutralità, la casualità regolata è uno strumento credibile.
Le elezioni. La sorte entra anche nell'amministrazione elettorale: la legge (95/1989) istituì l'albo degli scrutatori e il sorteggio pubblico; altre riforme successive hanno riaperto spazi alla nomina delle Commissioni elettorali, ma molti Comuni hanno mantenuto la "lotteria" come regola di trasparenza; si parte da un elenco, formato per requisiti, e poi si estrae.
La morale è che l'Italia già sorteggia dove serve togliere discrezionalità: giurie, revisori, commissari per l'abilitazione scientifica, in passato commissari di gara, persino le materie del concorso per magistrato, ovviamente il Tribunale dei ministri che, ricordiamo, è un collegio giudicante per trattare i reati più politicamente sensibili. Di fronte a un inventario del genere il sorteggio temperato sembra più un'estensione coerente e meno che mai una rivoluzione, anche perché non scarica il merito e comunque, dopo il referendum, si potrà discutere di dettagli tecnici come soglie e incompatibilità e quote. Ma la casualità, regolata, purtroppo è più onesta dell'uomo, così pare.